Su Stampa Diocesana, l’articolo del Direttore
“Sulla scuola gravano tutti i problemi che le altre istituzioni trascurano”
Anche quest’anno la scuola si ritrova alla partenza del 1° settembre: si comincia con il Collegio docenti, ci si rincontra con persone nuove, con i colleghi di anni, si ricorda chi si è trasferito e si parte…
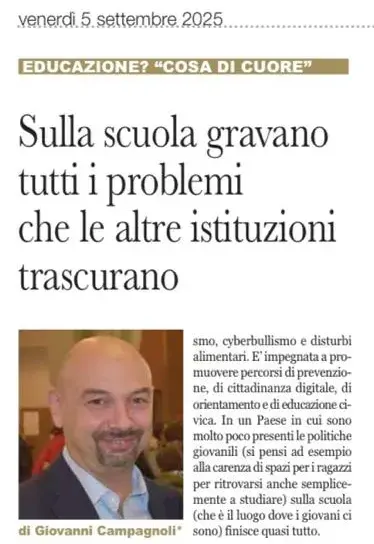
Si riprende, ricordando le ultime questioni dell’estate che avevano sollevato clamore: la protesta contro la formula attuale dell’Esame di Stato con il “silenzio” all’orale di alcuni maturandi, i successi scolastici nelle regioni del Sud Italia (dove si registrano le maggiori incidenze di voti alti ed altissimi), la crescita del numero dei diplomati in Italia, la riduzione della dispersione scolastica esplicita, ma l’aumento di quella implicita. Questa è la percentuale di studenti di Quinta superiore che conclude l’ultimo anno con competenze di base del tutto inadeguate, che è arrivata al 9,7% (dal 7% pre-Covid), con punte del 12% tra gli studenti con difficoltà di apprendimento.
Se il costruire ambienti di apprendimento (e non “spazi”) che favoriscano il successo scolastico e formativo in generale è la mission della scuola, il rischio è che la ripresa costringa invece a concentrarsi sui problemi di sempre: difficoltà di organico, carenza di spazi, lavori in corso, novità legislative. Tra queste i media pongono molto l’accento sia sul divieto dell’uso dello smart phone nelle scuole, sia sulle Linee guida sull’Intelligenza Artificiale nella didattica. D quest’anno c’è anche la legge 22/2025 che ha introdotto lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali (soft e life skills) nei percorsi scolastici. La legge mira a promuovere abilità come l’empatia, la gestione delle emozioni, la resilienza, il pensiero critico, il lavoro in team e la capacità di risolvere problemi, considerate fondamentali per la crescita personale e per affrontare il mondo del lavoro e della vita in generale. Infine, va a sistema la Nota Ministeriale 2443/2025 con le “Nuove regole su verifiche e compiti” che richiede ai Consigli di classe di bilanciare i carichi di verifiche in classe e compiti a casa, con una pianificazione trasparente e coordinata tra i docenti, garantendo ai ragazzi tempi adeguati ad organizzare il proprio studio.
In queste premesse rischia di esserci tutto ed il contrario di tutto: si vuole una scuola che vada oltre i voti ed oltre i libri, con questa sperimentazione sull’apprendimento di competenze, che sia più “difficile” (quindi più selettiva), ma anche inclusiva contrastando la dispersione scolastica, giusta nelle valutazioni, capace di vietare (smart phone) e punire con i voti di condotta (il cinque equivale ad una bocciatura, con il sei bisogna realizzare un elaborato critico su temi di cittadinanza). Oltre a tutto ciò, la scuola deve contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, i disturbi alimentari, promuovere percorsi di prevenzione, di cittadinanza digitale, di orientamento, educazione civica (queste oggetto di due ultime due leggi). In un Paese in cui sono molto poco presenti le politiche giovanili (si pensi ad esempio alla carenza di spazi per i ragazzi per ritrovarsi anche semplicemente a studiare insieme), sulla scuola (che è il luogo in cui i giovani ci sono) finisce quasi tutto…
Quindi?
Quindi organizziamoci: ogni istituzione scolastica ha la possibilità di utilizzare la propria “autonomia” per progettare un’offerta formativa che sappia comprendere il contesto, ascoltare esigenze di genitori e ragazzi, valorizzare le competenze del team docenti ed elaborare una formula. Va ricordato che il PNRR ha messo a disposizione delle scuole che progettano tantissime risorse, per cui il discrimine sempre di più sarà tra chi sceglierà di cogliere queste opportunità e chi no. In questo contesto anche le Scuole paritarie stanno giocando la partita, rispetto sia alle risorse a disposizione (molto più limitate…), sia alle capacità di progettazione.
Nessuno può dichiarare di avere la ricetta magica sulla scuola, ma dal ruolo di Neodirettore del don Bosco di Borgomanero (No), vedo che tutte le istituzioni possono però contribuire a costruire comunità educanti, non solo didattiche. Gli orientamenti dei provvedimenti legislativi degli ultimi anni contengono molto di questo: si possono ritrovare tanti principi educativi condivisi da don Bosco negli articoli della recente normativa scolastica. Non è un caso che oggi la Scuola salesiana stia crescendo di iscrizioni e progetti perché – paradossalmente – è molto più di una scuola. È un ambiente educativo, dove nella fase più importante della vita di ragazze e ragazzi (dagli 11 ai 19 anni), ci si ritrova in un luogo che sviluppa intenzionalmente relazioni, di apprendimento, educative, amicali. Il bisogno di adolescenti è confrontarsi con adulti significativi, coerenti, appassionati e “colorati”. La scelta di formare docenti-educatori, tutor, educatori di giovani che stanno sempre in mezzo ai ragazzi, nel cortile e nei tempi informali, permette proprio di crescere in luoghi “sani”, avendo a cuore il bene delle persone. E l’educazione (diceva don Bosco) è “cosa di cuore” ed al centro di ogni progetto ci devono essere ragazze e ragazzi.












